REPORTAGE ESCLUSIVO da Kabul, Afghanistan – La pax talebana di Kabul: tra crisi economica e incertezza per il futuro
Sul centro di Kabul cade una fitta neve che imbianca la città ma non ne ferma la vita caotica. Le strade sono brulicanti di persone, bancarelle ovunque, fumi, urla. Interminabili gruppi di persone di età indefinita siedono sui giacigli delle strade a fumare oppio. Ad ogni angolo bambini sporchi e vestiti in abiti tradizionali si attaccano con insistenza alle maniche delle giacche dei passanti chiedendo qualche soldo. Costantemente si incrociano posti di blocco dei mujahiddeen talebani: ragazzi di età generalmente compresa tra i 15 e i 25 anni, capelli lunghi, barbe incolte, spesso grossi anelli alle dita. Ognuno ha con sé un kalashnikov, chi a tracolla sulla spalla chi impugnato tra le mani. Indossano larghe tuniche oppure divise militari ornate con toppe bianche e nere ricoperte di scritte che recitano la shahadat islamica. Le stesse scritte che si vedono sulle bandiere che sventolano ovunque. Per le strade, sui pick-up che scorrazzano in giro, sui palazzi governativi.
Quattro mesi dopo la ritirata delle truppe occidentali, la vita a Kabul è permeata dagli usi e dai costumi talebani, diventati le nuove leggi non scritte dell’Emirato Islamico dell’Afghanistan. Ma soprattutto dalla povertà. Restano presenti per le strade e nei bazar i residui delle precedenti occupazioni straniere che hanno segnato la storia moderna dell’Afghanistan. Una storia raccontata proprio dai bazar. Quando l’Unione Sovietica occupò il Paese nel 1979, venne aperto nel centro della capitale un grande mercato a cielo aperto chiamato Brezhnev bazaar. I sovietici se ne andarono nel 1989 e dopo 11 anni di guerra civile (1989-1994) e di regime talebano del Mullah Omar (1994-2001) nel 2001 il Paese venne occupato dalle truppe della Nato. Il governo filoccidentale che instaurarono battezzò un altro grande mercato nel cuore di Kabul con il nome di Bush bazar, in onore del presidente americano. Lo scorso agosto i talebani lo hanno ribattezzato mujahiddeen bazar. Al suo interno fiorisce paradossalmente il commercio delle reliquie sovietiche e americane lasciate sul territorio dagli ex occupanti. Intere bancarelle vivono oggi vendendo prodotti raccolti nelle basi che le truppe della NATO hanno abbandonato in fretta e furia lo scorso agosto: divise militari, giubbotti antiproiettile, scarponcini, kit medici. Prodotti che vengono acquistati perfino dai talebani.
Per sopravvivere è lecito commerciare qualsiasi cosa. Oggi i nemici degli afghani non sono i russi, gli americani o i mujahiddeen, bensì il freddo, la neve, la scarsità di elettricità, la mancanza di viveri. Con la loro evacuazione lo scorso agosto, gli Stati Uniti hanno congelato le riserve finanziarie dello Stato afghano per evitare che finissero nelle mani del nuovo governo talebano. Da allora i dipendenti pubblici non percepiscono più lo stipendio, il valore della moneta afghana è crollato, decine di migliaia di ex collaboratori delle truppe occupanti, delle ong e dei media finanziati dall’Occidente sono rimasti disoccupati. Per le strade e nelle case non si parla tanto di politica ma piuttosto di come sopravvivere. Qualcuno critica i talebani, altri invece si dicono pronti a sostenerli purché riescano a sfamare la gente.
La salita al potere dei mujahiddeen non comporta semplicemente il ritorno ai tempi del Mullah Omar. Al contrario, la quotidianità dei cittadini è scandita da notevoli differenze rispetto ad allora. Per le strade alcuni uomini vestono all’occidentale, con jeans e camicie. Diverse donne camminano da sole, alcune indossano il velo integrale azzurro che copre loro tutto il volto ma tante altre hanno semplicemente un foulard appoggiato sul capo che lascia intravedere abbondanti ciocche di capelli, in stile iraniano. Nei negozi di parrucchieri vengono esposte scatole di prodotti femminili che mostrano ragazze con il volto scoperto. Alcuni ragazzi sprezzanti del pericolo ascoltano la musica nelle case e nelle auto. Tutte cose proibite dall’ideologia talebana che nel periodo precedente sarebbero state immediatamente punite. Oggi invece i mujahiddeen adottano una linea più permissiva. Hanno colto la lezione dell’ultima volta e capito che l’ortodossia li porta ad essere isolati internazionalmente, racconta Mohamed Andalib Ismail, giornalista afghano dell’agenzia Afghan Islamic Press, si rendono conto che con la rapidità del web le violenze brutali farebbero rapidamente il giro del mondo compromettendoli come potenziali interlocutori.
L’obiettivo primario dei talebani è infatti quello di farsi riconoscere dal mondo come legittimi governatori dell’Afghanistan. Oggi l’Emirato Islamico non è formalmente riconosciuto da nessuno, seppure molti Paesi intrattengano rapporti informali con esso. Tra questi ci sono Cina, Russia, Pakistan, Turchia, Qatar, Iran, Emirati Arabi ed Indonesia. Anche gli Stati Uniti hanno dialogato con i talebani a partire del 2010, mentre le due parti si combattevano sul campo di battaglia afghano. Entrati in clandestinità nel 2001, per vent’anni i talebani hanno condotto una incessante guerriglia contro le forze di occupazione. Nel 2018 l’amministrazione Trump avviò un negoziato ufficiale in vista del disimpegno statunitense. Resisi conto della debolezza e della profonda corruzione del governo filoccidentale che avevano instaurato a Kabul, gli americani avrebbero voluto che una volta ritiratisi questo coesistesse con i mujahiddeen, possibilmente formando una coalizione di governo di larghe intese. Un progetto infrantosi rapidamente lo scorso agosto quando l’evacuazione statunitense è corrisposta al collasso totale del governo e alla conquista del potere dei talebani nell’arco di ventiquattro ore.
Da allora Kabul e tutto l’Afghanistan vivono una sorta di “pax talebana”. Una caotica atmosfera di povertà e di apparente sicurezza militare in cui le opinioni sull’Emirato Islamico divergono. Tutti sono d’accordo sul fatto che con l’arrivo dei talebani è diminuita la corruzione e si vive in modo più sicuro. I vent’anni di presenza occidentale vengono ricordati come un periodo di pericolo costante. In primis a causa della guerra tra forze di occupazione e mujahiddeen. Alla guerriglia talebana gli eserciti della Nato rispondevano con regolari attacchi sia aerei che terrestri per tentare di fiaccare il nemico, colpendo massicciamente anche i civili. In questo ventennio le vittime sia militari che civili sono state circa 176 mila. Quasi nessuno ha avuto giustizia. Non l’ha avuta Abduld Quayum, padre di famiglia di 57 anni che vive nella città di Ghazni, roccaforte dei talebani non lontano dal Pakistan. Nel 2018 durante una feroce battaglia tra mujahiddeen e forze di occupazione, la NATO bombardò la casa di suo fratello causando 16 vittime: uomini, donne, bambini. Quando Abdul andò dal governo filoamericano a chiedere giustizia la risposta fu: siamo in guerra, possono succedere degli incidenti. La responsabilità è dei talebani che hanno attaccato.
Non ha avuto giustizia nemmeno Masoum Khan, contadino originario della regione di Paktika. Aveva 12 anni quando nel 2008 le forze della Nato attaccarono il suo villaggio uccidendo 34 civili, di cui 10 della sua famiglia. In quell’occasione le truppe occidentali prima bombardarono, poi entrarono via terra nel villaggio e fecero irruzione in casa sua sparando ad altezza d’uomo. Tra le 10 vittime vi furono anche sua madre e suo fratello di 3 anni, entrambi colpiti alla testa da un proiettile. Siamo contenti che gli americani se ne siano andati, non ci hanno lanciato fiori ma proiettili, dice oggi Masoum, ora noi non possiamo avere giustizia ma prima o poi la avremo perché loro non hanno fatto nulla di buono.
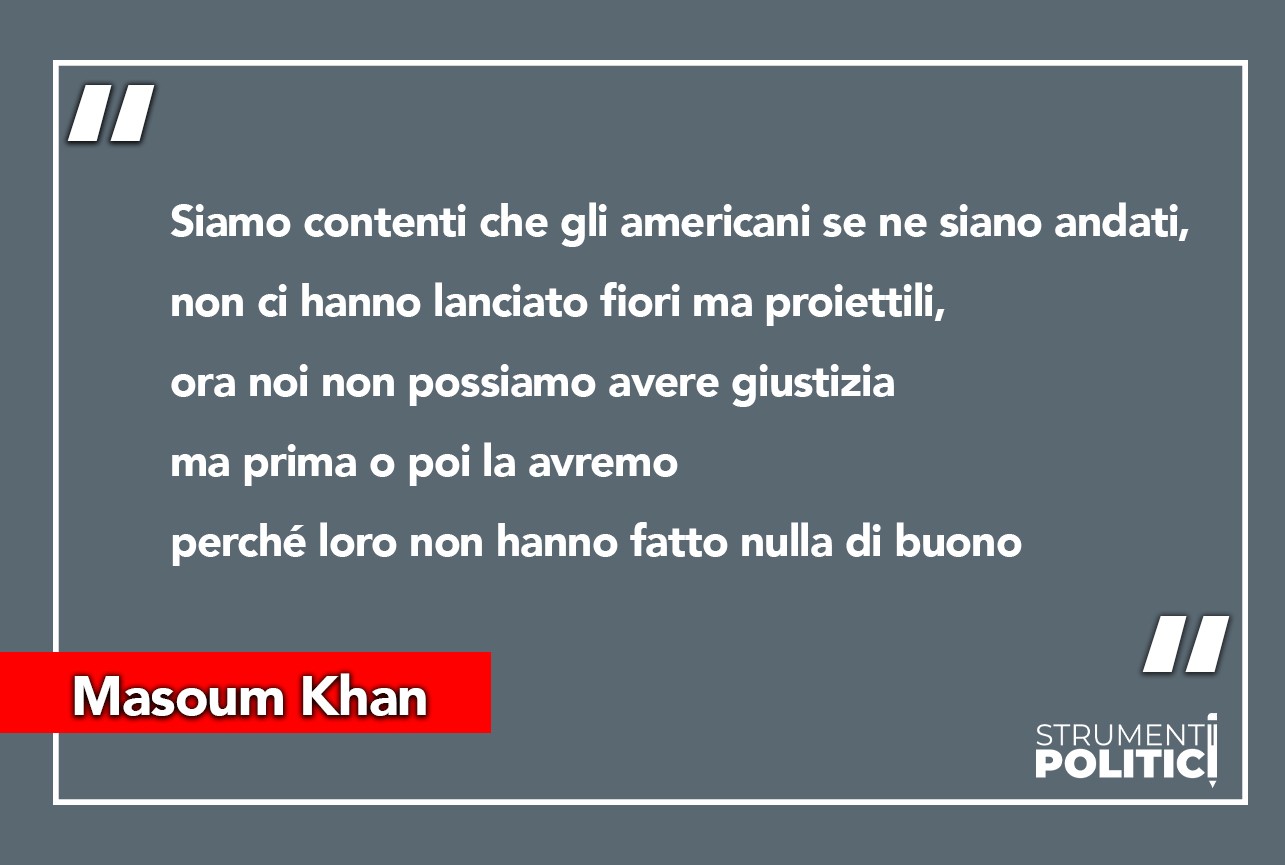
Si dicono invece scontentI dei talebani gli ex funzionari del governo filoccidentale, gli ex dipendenti delle ong occidentali ed i giornalisti che lavoravano per i media finanziati dall’Occidente. È il caso di Nafisa Hotak, giornalista di ventiquattro anni che fino ad agosto lavorava per una radio finanziata da alcuni Paesi della NATO. Con l’arrivo dei talebani abbiamo smesso di ricevere finanziamenti e quindi di lavorare, racconta. Per questi motivi molti giornalisti hanno lasciato il Paese e le loro testate hanno chiuso. Circa il 50% dei media afghani ha smesso di essere attivo. Chi ancora lavora sul territorio fronteggia grossi problemi: economici legati allo stop dei finanziamenti dall’estero; professionali legati alle restrizioni imposte dai talebani. Niente più musica alla radio e in tv, chiusura dei programmi femminili, invito alle donne a non lavorare. Oggi molte giornaliste sono dunque disoccupate. Nafisa, invece, è stata assunta da un’agenzia nazionale cinese, eppure continua ad avere problemi. Un giorno ho ricevuto una telefonata dai talebani che mi hanno detto di parlare positivamente del nuovo governo e non mostrarne i lati negativi racconta. Inoltre, le direttive della mia attuale agenzia sono di parlare bene di loro. I reportage che non si attengono a questa linea non vengono pubblicati.
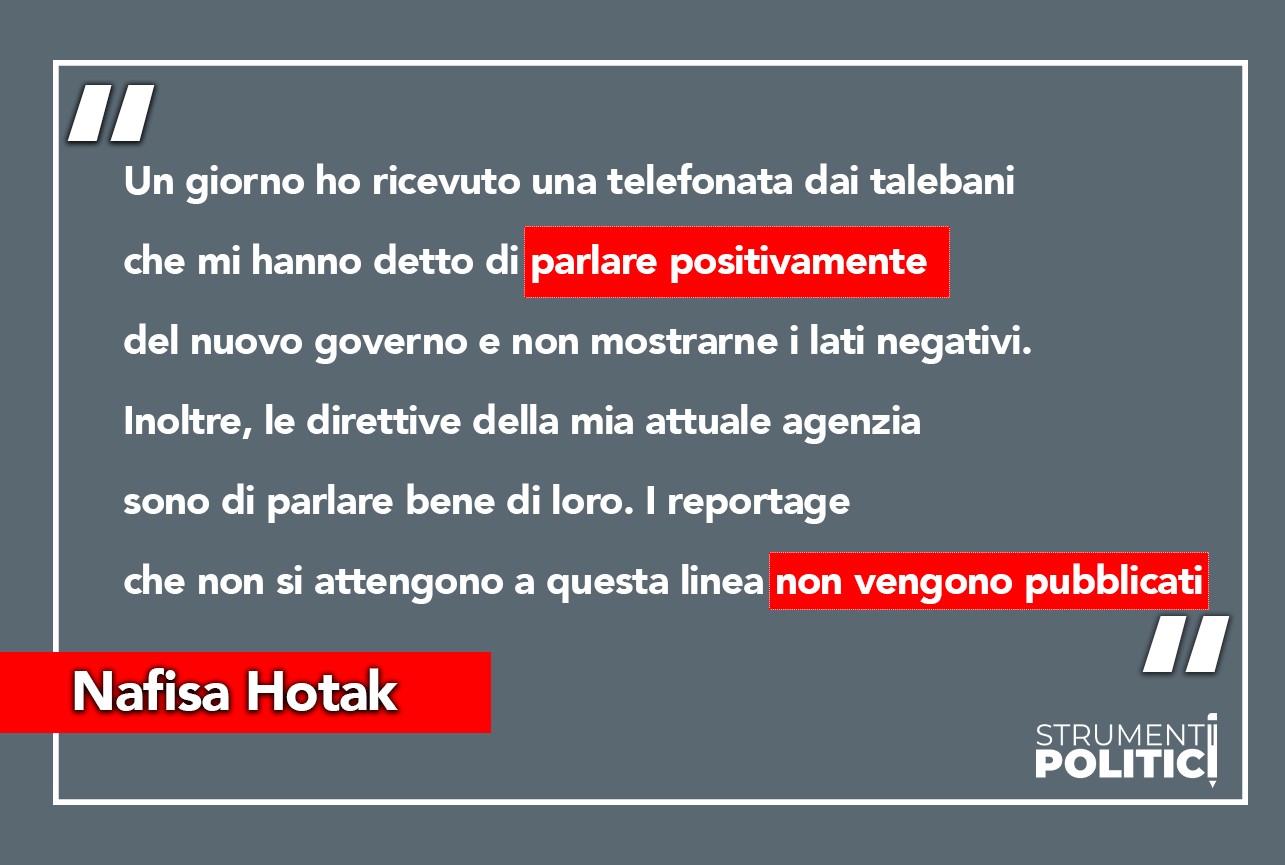
Non verremo mai accettati dai talebani perché ci considerano collaborazionisti degli ex occupanti, dice Bilal (nome di fantasia per motivi di sicurezza), ex dipendente della Afghan Independent Human Rights Commission, organo creato sotto il governo filoccidentale. Con la fondazione dell’Emirato, i 400 dipendenti hanno smesso di andare al lavoro per paura di ripercussioni. Fino ad oggi non mi hanno mai minacciato – continua – ma non stanno mostrando il loro vero volto per paura di reazioni della comunità internazionale. La loro è solo una tattica. Appena avranno l’occasione torneranno ad imporre il loro ordine ortodosso.
La neve non smette di cadere su Kabul ed i fiocchi si attaccano dappertutto. Sui marciapiedi, sulle tende delle bancarelle, sulle divise dei talebani ai posti di blocco che cercano di ripararsi sotto caldi mantelli di lana. Per le strade e nei bazar centinaia di persone sgomitano per cercare rapidamente riparo, chi spingendo un carrello, chi portando grossi sacchi sulle spalle, che sgommando su biciclette e motorini. Con l’arrivo del freddo c’è sempre meno tempo per parlare di politica, dei talebani, degli americani, dell’Emirato. I problemi imminenti sono altri: assenza di elettricità, disoccupazione, crisi economica, mancanza di beni di prima necessità. A Kabul la situazione è generalmente migliore rispetto alle province, eppure anche qui la speranza per il futuro è poca. Sia tra chi sostiene i mujahiddeen sia tra chi li critica.

Giornalista, reporter e analista geopolitico. Ha pubblicato reportage e interviste da Germania, Ungheria, Polonia, Russia, Cina, Afghanistan, Turchia, Siria, Libano, Giordania, Armenia, Ecuador. Collabora in Italia con Sky TG24, Il Giornale, L’Espresso e Huffington Post, in Germania con Ard, Die Welt e Deutsche Welle, in Svizzera con RSI Radiotelevisione svizzera e Corriere del Ticino. Tiene corsi di geopolitica presso la Facoltà di Teologia dell’Università di Lugano. È analista geopolitico di Limes.














