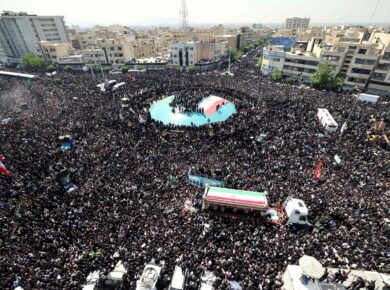Tunisia si dota di una propria area Sar, obiettivo: salvare vite nel Mediterraneo
La Tunisia ha ufficialmente formalizzato la propria Zona di ricerca e salvataggio in mare (Sar), impegnandosi a fornire assistenza alle persone in pericolo in mare, dopo aver istituito il Centro nazionale per il coordinamento delle operazioni di ricerca e salvataggio marittimo (Tnmrcc), che da qualche giorno figurano nel Piano Sar globale dell’autorità marittima internazionale (Imo) delle Nazioni Unite.
La Tunisia è membro dell’Imo dal 1963, organizzazione che ha assunto un ruolo guida nel miglioramento degli standard di sicurezza sin dalla sua istituzione nel 1948. La posizione geografica della Tunisia nel Mediterraneo centrale ha evidenziato la grande importanza del mantenimento degli standard di sicurezza e protezione e dell’obbligo di prestare assistenza alle persone in pericolo in mare.
Il processo di attivazione della convenzione Sar
Sebbene la Tunisia abbia aderito alla convenzione Sar del 1979, il 31 luglio 1998, la sua zona di responsabilità Sar, ufficializzata oggi, non era stata delimitata fino all’inizio del 2020. Le coordinate di tale zona sono state sottoposte alla sottocommissione per la navigazione, le comunicazioni e la ricerca e il salvataggio (Ncsr) ed hanno finalmente ricevuto l’approvazione da parte dell’Imo.
Tale delimitazione definitiva della zona di responsabilità Sar che è quella rimanente dagli accordi già esistenti tra Italia, Libia e Malta, e l’organizzazione delle operazioni di ricerca e salvataggio, sono state formalizzate solo di recente attraverso il decreto n. 181, pubblicato il 5 aprile 2024 in Gazzetta Ufficiale dello Stato, denominato “Aiuto e salvataggio delle persone in pericolo in mare”, creando a tale scopo un’amministrazione pubblica, che sancisce di fatto l’adesione della Tunisia alla Convenzione di Amburgo o Convenzione Sar.
Il ruolo della Guardia costiera tunisina
Responsabile dell’autorità nazionale dei servizi di ricerca e salvataggio in mare è il comandante del servizio nazionale di Guardia costiera tunisina. Il decreto 181 ha de facto istituito un’unità nell’ambito del servizio nazionale di sorveglianza costiera incaricata di rafforzare l’efficacia dei servizi di ricerca e salvataggio in mare e di coordinare l’avanzamento delle operazioni, denominata Centro nazionale per il coordinamento delle operazioni di ricerca e salvataggio marittimo responsabile in particolare della Guardia operativa 24 ore su 24 per ricevere chiamate di soccorso attraverso i mezzi di comunicazione richiesti in conformità con gli standard internazionali pertinenti.
Il nuovo Centro sarà diretto e supervisionato da un alto ufficiale del Servizio nazionale di sorveglianza costiera, nominato con ordinanza dal ministro della Difesa. Esso disporrà di tre centri di ricerca e salvataggio secondari, sotto il Servizio nazionale di sorveglianza costiera del ministero della Difesa, e di altri quattro centri di ricerca e salvataggio secondari, sotto la Direzione generale della Guardia nazionale, quest’ultima appartenente al ministero dell’Interno.
Le dotazioni
Nello svolgimento delle sue missioni, il Centro di coordinamento potrà avvalersi di unità navali e aeree del ministero della Difesa, del ministero dell’Interno e dei ministeri responsabili dei Trasporti, delle Dogane e della Pesca marittima, ma anche di aerei e navi della Repubblica tunisina e natanti battenti bandiera tunisina che si trovano in mare e che possono partecipare alle operazioni di ricerca e salvataggio.
Oltre alle navi della Marina tunisina, dunque, le squadre nautiche della Guardia nazionale e le motovedette della Guardia costiera, diversi servizi ed enti possono contribuire alle attività Sar come il servizio idrografico e oceanografico della Marina tunisina, l’Istituto meteorologico nazionale del ministero dei Trasporti, aerei ed elicotteri dell’aeronautica militare, elicotteri della Guardia nazionale, navi della dogana tunisina, rimorchiatori pubblici e privati. Per questo, il dipartimento appena creato è responsabile del coordinamento delle azioni delle diverse parti interessate e del miglioramento del processo di attuazione delle convenzioni marittime internazionali nel diritto nazionale.
Le pressioni estere per la formalizzazione dell’area Dar
La formalizzazione dell’area Sar da parte della Tunisia, giunge sullo sfondo delle pressioni esercitate dai media e da alcuni partiti politici di opposizione che in Italia hanno accusato la Tunisia di non essere in grado di controllare i suoi confini marittimi, di respingere i migranti nel deserto e perfino di “affogare i migranti”. Così in Tunisia, il presidente Kais Saied è stato accusato da alcuni partiti di opposizione di aver ceduto ai ricatti dell’Ue ed in particolare dell’Italia.
Un clima esacerbato anche dalla forte polarizzazione del contesto internazionale, caratterizzato dalla competizione tra Cina e Stati Uniti, dall’offensiva russa in Ucraina e le mire del Cremlino in Africa e dal conflitto in Medio Oriente. Nonostante le promesse di aiuti europei, la risposta del governo tunisino è sempre stata chiara, non avrebbe consentito alcuna ingerenza nei suoi affari interni pur garantendo di mantenere fede ai suoi impegni internazionali e l’adesione ai principi umanitari sanciti dal diritto internazionale.
Lo stop all’obbligo di visto
A questo proposito, gli sforzi messi in atto dalle forze dell’ordine e principalmente dalla Guardia nazionale per la sicurezza e il pattugliamento delle frontiere marittime, hanno contribuito a diminuire il numero di operazioni di migrazione illegale. Recentemente, la Tunisia è diventata un paese ospitante per i migranti sub-sahariani e il loro numero è cresciuto soprattutto dopo l’abolizione dell’obbligo del visto per un certo numero di paesi sub-sahariani e l’accordo del 2018 tra Libia e Italia con il quale la Guardia costiera libica ha aumentato le pattuglie per respingere i migranti illegali.
Il punto di partenza preferito è diventato quindi le coste tunisine o il confine terrestre tra Libia e Tunisia, che consentono viaggi più brevi e sicuri verso le coste italiane e più specificatamente verso le due isole di Lampedusa e Pantelleria. Da un punto di vista pratico, la maggior parte delle operazioni di migrazione illegale intercettate dalla Guardia nazionale sono state quasi sempre considerate operazioni di salvataggio a causa della non navigabilità delle imbarcazioni usate e delle minacce che le “barche della morte” rappresentano per la vita dei migranti.
Alcuni dati
“Agenzia Nova”, che ha intervistato il portavoce della Guardia nazionale tunisina, segnala che i migranti intercettati e salvati in mare nel solo mese di maggio sono stati 8.736, contro i 4.076 di maggio 2023, in 290 operazioni contro le 245 di maggio dell’anno scorso. Dall’inizio dell’anno al 31 maggio 2024 sono state condotte 1.041 operazioni in mare, 40 in più dello stesso periodo dell’anno precedente quando erano state registrate 1.001 attività di ricerca e salvataggio in mare.
“L’obiettivo della creazione di un sistema nazionale di ricerca e salvataggio marittimo – ha precedentemente spiegato il ministro della Difesa tunisino, Imed Memmich – è quello di migliorare l’efficacia dell’intervento dello Stato in questo campo, al fine di fornire servizi di ricerca e salvataggio marittimo a tutti gli utenti tunisini e non tunisini del mare nell’area di responsabilità tunisina, in particolare ai pescherecci tunisini, alle navi passeggeri, alle imbarcazioni commerciali e alle imbarcazioni da diporto“.
Parlando dal quartier generale della base navale di La Goulette, durante il lancio della prima edizione dell’esercitazione di ricerca e salvataggio marittimo “Safe Sea 24” nel Golfo di Tunisi, che si è concluso lo scorso 29 maggio, Memmich ha ribadito che la “Tunisia adempie ai suoi obblighi e impegni internazionali”, pur riaffermando la propria sovranità nazionale.
La centralità della Convenzione di Amburgo
La Convenzione di Amburgo, adottata nel 1979 e a cui la Tunisia ha aderito, mira a sviluppare un piano Sar internazionale integrato in modo che, ovunque si verifichi un incidente, il salvataggio delle persone in pericolo in mare sia coordinato da un’organizzazione di ricerca e salvataggio e, ove necessario, attraverso la cooperazione tra organizzazioni di ricerca e soccorso dei paesi vicini.
L’obbligo per le navi di prestare assistenza alle imbarcazioni in pericolo è sancito dalle consuetudini e dai trattati internazionali (come la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (Convenzione Solas del 1974), ma, fino all’adozione della Convenzione Sar, non sono stati forniti accordi internazionali relativi alle operazioni di ricerca e salvataggio. Mentre in alcune regioni esisteva un’organizzazione ben consolidata che consentiva di fornire un’assistenza rapida ed efficace, in altre regioni come in Tunisia mancava completamente.
I requisiti tecnici sono stabiliti in un allegato suddiviso in cinque capitoli. Le parti della Convenzione sono tenute a garantire che siano presi accordi per fornire i necessari servizi di ricerca e salvataggio nelle loro acque costiere. Sono invitati a concludere accordi di ricerca e salvataggio con gli Stati confinanti che prevedano la delimitazione delle regioni Sar, la condivisione delle loro risorse, lo sviluppo di procedure comuni, la formazione e il coordinamento.

Vanessa Tomassini è una giornalista pubblicista, corrispondente in Tunisia per Strumenti Politici. Nel 2016 ha fondato insieme ad accademici, attivisti e giornalisti “Speciale Libia, Centro di Ricerca sulle Questioni Libiche, la cui pubblicazione ha il pregio di attingere direttamente da fonti locali. Nel 2022, ha presentato al Senato il dossier “La nuova leadership della Libia, in mezzo al caos politico, c’è ancora speranza per le elezioni”, una raccolta di interviste a candidati presidenziali e leader sociali come sindaci e rappresentanti delle tribù.
Ha condotto il primo forum economico organizzato dall’Associazione Italo Libica per il Business e lo Sviluppo (ILBDA) che ha riunito istituzioni, comuni, banche, imprese e uomini d’affari da tre Paesi: Italia, Libia e Tunisia. Nel 2019, la sua prima esperienza in un teatro di conflitto, visitando Tripoli e Bengasi. Ha realizzato reportage sulla drammatica situazione dei campi profughi palestinesi e siriani in Libano, sui diritti dei minori e delle minoranze. Alla passione per il giornalismo investigativo, si aggiunge quella per l’arte, il cinema e la letteratura. È autrice di due libri e i suoi articoli sono apparsi su importanti quotidiani della stampa locale ed internazionale.